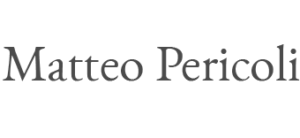Esattamente vent’anni fa, il 28 ottobre 2001, andò in onda su CBS Sunday Morning un servizio di 5 minuti su Manhattan Unfurled.

di Matteo Pericoli
Più che in altre tecniche di rappresentazione, nel disegno al tratto il processo decisionale e le conseguenti omissioni possono essere lette con chiarezza. Un disegno fatto di sole linee deve parlare in modo deliberato e chiaro. Lo schizzo, la pittura o la fotografia hanno un rapporto meno filtrato con la realtà. Trasferiscono in modo più diretto (compatibilmente con la tecnica stessa) come il cervello interpreta il mondo.
Un disegno fatto di linee compiute (cioè con un chiaro inizio e una fine) prima di diventare tale deve attraversare un ulteriore processo analitico durante il quale chi disegna si domanda «ho bisogno di quest’altra linea per descrivere ciò che ho già mostrato con questa?» oppure «di quante linee ho bisogno per rendere questo dettaglio il più chiaro possibile senza usare troppe linee?».
I disegni al tratto sono ovviamente strettamente imparentati con (o provengono dai) disegni architettonici — disegni per lo più tecnici, ricchi di dettagli e con proprie regole sintattiche. Infatti, sono spesso dei “documenti” il cui compito è trasmettere informazioni ben precise sia sull’estetica sia sui dettagli di un edificio. Più è chiaro un disegno architettonico, più è facile “leggere” le qualità compositive e costruttive di un progetto.
Stavo ancora lavorando nello studio dell’architetto Richard Meier quando, nel 1998, decisi di provare a usare quelle stesse linee che usavo al lavoro per raccontare Manhattan nella sua interezza. Avevo appena preso il battello della Circle Line e circumnavigato l’isola per cercare di vedere ciò che m’era stato fino a quel momento invisibile (standoci dentro): la città stessa. Avevo deciso di provare a trasferire quel progredire lento e rivelatore della gita in battello in un disegno anch’esso lungo e dettagliato (ci sono poi voluti anni per completare i due rotoli dei profili est e ovest di Manhattan) che mostrasse tutto invece di solo alcune parti.
In fondo, una questione che mi assillava da quando mi trasferii a New York nel 1995 era proprio che la città veniva descritta a pezzi, aree, quartieri — con i famosi edifici che svettano sugli altri e con poco rapporto col resto — ma sembrava difficile da afferrare in modo integrale. Mi domandai: che impressione mi farà alla fine l’aver disegnato tutto senza alcuna esclusione? E se disegnerò ogni cosa che si vede dal fiume con il minor numero di linee possibile, con delle onde buffe, senza mai misurare o usare un righello, il risultato sarà un qualcosa di vivo come la città stessa? Qualcosa con cui i bimbi vorranno interagire? Che vorranno colorare?
Il disegno al tratto è innanzitutto uno strumento cognitivo. Nel voler provare a disegnare tutto, cioè ogni cosa, speravo di arrivare a conoscere meglio e poter condividere la città come fosse, appunto, un unico oggetto. Mi resi conto ben presto che quel tutto che stavo disegnando in Manhattan Unfurled era molto di più della somma di tutte le sue piccole parti; che disegnando ogni cosa si finisce sì per imparare molto, ma anche che non è ben chiaro cosa si impari. È una diversa forma di conoscenza. È forse più un senso di profonda familiarità o intimità verso un luogo che non è più solo fisico.
Lo stesso accadde anni dopo con London Unfurled, l’altro progetto di disegno urbano su due lunghi rotoli di carta. Nel caso di Londra, nel giro di alcuni mesi passai dal non sapere praticamente nulla di una città dove non avevo mai vissuto a conoscerne tutti gli edifici che si affacciano sul Tamigi. Durante il lavoro, tutto quello che disegnavo del profilo di Londra mi si fissava in testa linea dopo linea, spesso prendendo il posto dell’immaginario che mi stavo creando della città dove mi ero appena trasferito (Torino).
Per riuscire a osservare e fare veramente nostra una cosa è quindi necessario disegnarla, a mano libera e possibilmente al tratto, cioè con delle linee ragionate. Per quello che mi riguarda, non c’è altro modo. Dopo sette anni che ci vivevo accanto, dovetti infatti disegnare la vista dalla mia finestra sull’Upper West Side di Manhattan per accorgermi che non l’avevo mai veramente vista. Finestre sul mondo (e, prima, The City Out My Window) nasce dal desiderio di svelare, tramite il disegno, quanto la quotidianità di ciò che si trova al di fuori della nostra finestra sia spesso invisibile ai nostri occhi inconsapevoli. E come, soffermandoci su ciò che abbiamo sempre sotto il naso, il nostro sguardo non finisca per riflettersi su di noi.
La collaborazione con gli scrittori di Finestre sul mondo non ha fatto altro che rafforzare quanto, come nella scrittura, il potenziale narrativo del disegno al tratto si nasconda nella qualità di ogni singola linea — nella sua abilità cioè, in quella precisa posizione e in nessun’altra, di trasmettere il massimo delle informazioni con il minimo sforzo di lettura.
di Vincenzo Latronico
Rane – Il Sole 24 Ore – 29 settembre 2015
Tecnicamente sarebbe
un “workshop interdisciplinare”.
In pratica, è uno
strabiliante esperimento
intellettuale in grado di
mettere insieme le forbici
con la punta arrotondata
e i racconti di Kafka
In un torrido pomeriggio di inizio luglio stavo parlando con due amici di un testo di Amy Hempel intitolato Il Raccolto. Racconta la storia di un incidente d’auto capitato all’autrice, e poi la racconta di nuovo: elencando le omissioni e gli aggiustamenti fatti alla prima versione per renderla efficace e brillante, svelando le piccole insicurezze di chi scrive, le bugie e le vergogne. L’effetto è accattivante e straniante allo stesso tempo. Alla fine la prima storia – quella “romanzata” – non sta in piedi.
«Non si regge», ho detto. «La seconda parte gli toglie ogni punto d’appoggio».
«È vero», ha detto Stefania. «Servirebbe un pilastro».
Non era una metafora per riferirsi a una frase efficace. Stefania parlava proprio di un pilastro. La prima parte del racconto della Hempel era un osservatorio a picco su una montagna, scavato all’interno di un salone più grande che era la seconda, e non si reggeva.
Poi abbiamo aggiunto un pilastro, che Andrea ha ritagliato nel cartoncino vegetale, e allora sì.
Eravamo al Laboratorio di Architettura Letteraria, uno strabiliante esperimento intellettuale portato avanti da Matteo Pericoli, architetto e disegnatore. Tecnicamente è un “workshop interdisciplinare”, ma il termine è un po’ urticante e calza male a una situazione in cui sono presenti in egual misura Kafka e forbici con la punta arrotondata.
Per introdurre il tema del laboratorio, Pericoli cita spesso un brano di Alice Munro: «Una storia non è una strada da percorrere (…) è più come una casa. Ci entri e ci rimani per un po’, andando avanti e indietro e sistemandoti dove ti pare, scoprendo come le camere stiano in rapporto col corridoio, come il mondo esterno viene alterato se lo guardi da queste finestre. E anche tu, il visitatore, il lettore, sei alterato dall’essere in questo spazio chiuso, ampio e facile o pieno di svolte e angoli che sia, pieno oppure vuoto di arredamento. [Questa casa] trasmette anche un forte senso di sé, di essere stata costruita per una sua necessità, non solo per fare da riparo o per stupirti».
L’idea di fondo del laboratorio è che questa metafora – che il percorso del lettore in un libro è simile al percorso di una persona in uno spazio – può essere presa sul serio; e che l’architettura può essere usata come strumento concettuale per analizzare e comprendere una storia, disegnandone un progetto strutturale e costruendone letteralmente un modello.
Strutture, vuoti, scale
 In passato i corsi si sono tenuti in varie forme alla Columbia University di New York e alla Scuola Holden di Torino, in scuole superiori statunitensi e all’Università di Ferrara; io ho preso parte a un’iterazione che si è svolta all’interno del festival “Architettura in città” dell’Ordine degli Architetti di Torino.
In passato i corsi si sono tenuti in varie forme alla Columbia University di New York e alla Scuola Holden di Torino, in scuole superiori statunitensi e all’Università di Ferrara; io ho preso parte a un’iterazione che si è svolta all’interno del festival “Architettura in città” dell’Ordine degli Architetti di Torino.
Eravamo in quindici, tutti architetti presenti o futuri a parte me; faceva un caldo brutale fuori dai magazzini OZ, l’associazione che ci ospitava. Dopo una breve introduzione di Pericoli, ci siamo divisi in gruppi in base ai testi che avevamo scelto. Ci siamo seduti a un tavolo, ci siamo presentati rapidamente e abbiamo cominciato a parlare del testo di Hempel. Era come se parlassimo di architettura. Dicevamo tensione, struttura, ritmo, aperture e chiusure, connessioni, passaggi, sequenze, vuoto. Dicevamo scena, che in realtà è il luogo dove le scene narrative si svolgono. Dicevamo climax, che significa scala.
Secondo il grande linguista George Lakoff le metafore non sono casuali: più sono cementate nel nostro linguaggio, più rivelano che l’affinità fra i due campi ha un reale fondamento cognitivo. È celebre l’esempio della matematica, di cui si parla spesso con metafora spaziale (numeri che si seguono, insiemi che contengono); Lakoff ha dimostrato che i processi mentali che attiva nel cervello sono gli stessi usati per orientarsi nel movimento.
Non so se ci sia un qualche fondamento cognitivo nell’idea che una storia è come una casa (ne dubito); quello che so è che parlare di una storia come se fosse una casa è un modo estremamente efficace per comprenderla.
Penso al nostro caso: tre sconosciuti seduti intorno a un tavolo che devono discutere di un testo che hanno letto. Le probabilità che qualcosa vada storto sono altissime: si può finire schiacciati dal silenzio imbarazzato, o smarriti nelle astrazioni sclerotizzate a cui ci abitua la scuola («intenzione dell’autore», «contesto storico»), o bloccati nel pantano del «secondo-me-lei-non-lo-amava-davvero».
A noi non è capitato nulla di tutto questo; la metafora architettonica ci ha indirizzati verso l’essenziale. La Hempel raccontava una storia, e poi l’episodio reale da cui questa era nata: e cioè l’episodio su cui questa si fondava, su cui si basava, che la racchiudeva. Questi sono termini spaziali, e ci è stato chiaro che la struttura del racconto si traduceva in due ambienti fra cui vigeva uno di quei rapporti.
La spirale di Dumas
 Mi è venuto immediato estendere questa procedura ad altri testi che conosco e amo.
Mi è venuto immediato estendere questa procedura ad altri testi che conosco e amo.
Democracy di Joan Didion – una storia d’amore raccontata in modo esploso, tornando ciclicamente alla stessa scena madre per poi diramarsi ogni volta in un momento diverso del passato dei due – è un labirinto in cui si ripassa sempre da una stanza centrale, vedendola ogni volta da prospettive diverse.
Il conte di Monte-Cristo di Alexandre Dumas, che racconta di una vendetta preparata per decenni, è una spirale ascendente: visto di fianco, è la storia di un’ascesa vertiginosa, visto da sopra è un percorso che porta esattamente al punto di partenza, e probabilmente finisce in uno strapiombo.
Questo è a tutti gli effetti un modo di visualizzare un’idea astratta, anzi, di toccarla con mano: finito il progetto ci siamo messi a realizzarne un modello. Oltre che essere molto divertente per me che passo la vita al computer (colla! taglierino!), questo ci ha permesso di scoprire aspetti di quell’idea che prima, al solo pensiero, non erano evidenti.
Ad esempio: tutto ciò che non è finito nel nostro progetto – i personaggi, le piccole scene, le battute di dialogo – si rivelava in qualche modo inessenziale; un personaggio poteva essere eliminato, una conversazione allungarsi o svolgersi altrove, ma l’esperienza complessiva del lettore non sarebbe cambiata in maniera cruciale. Questa è una verità che fa rabbrividire critici e teorici, ma che ogni lettore sa bene: in un romanzo, molta della superficie è secondaria o comunque rimpiazzabile, purché lo scheletro, progettato in ogni dettaglio e calibrato al microgrammo, resti inalterato. È quello scheletro che si costruisce nel modello. Vederne una prova sotto i miei occhi è stato sbalorditivo.
Ancora più sbalorditivo è stato rendersi conto che, alla fine del laboratorio, all’esposizione dei modelli, mi trovavo in una stanza con quindici persone che avevano passato tre giorni a discutere di teoria letteraria: ed era stato, inspiegabilmente, divertente e proficuo.
Lettori sudati
 Credo che sia qui la rilevanza profonda del laboratorio, che va ben al di là delle sfere ristrette di scrittori e architetti e ha a che fare col modo in cui si comprende e si insegna la letteratura.
Credo che sia qui la rilevanza profonda del laboratorio, che va ben al di là delle sfere ristrette di scrittori e architetti e ha a che fare col modo in cui si comprende e si insegna la letteratura.
Tempo fa, sulle pagine di questo giornale, lamentavo la pesantezza e l’inefficacia del suo insegnamento scolastico, che spesso la fa apparire come una montagna inespugnabile anziché come una fonte di gioia. Sostenevo che era anche per questo che si leggeva poco e male. Di recente mi ha risposto Giusi Marchetta con uno splendido saggio (Lettori si cresce, Einaudi 2015) in cui argomenta che è un bene che gli studenti vedano la letteratura come una montagna, perché la scuola deve opporsi al meccanismo della gratificazione istantanea e insegnare che i premi importanti vanno sudati.
La sua tesi mi ha convinto, eppure restavo – resto – dell’idea che le montagne siano spaventose e inospitali, e che se la letteratura viene mostrata come tale gli studenti continueranno a preferire le spiagge di Instagram e le piscine gonfiabili di Candy Crush.
Al laboratorio – facendo teoria letteraria con cartoncino e matite – ho visto un’altra possibilità. Su quella montagna ci si costruisce una casa.
Leggi sul sito del Sole 24 Ore:
https://st.ilsole24ore.com/art/cultura/2015-09-28/laboratorio-architettura-letteraria-184136.shtml