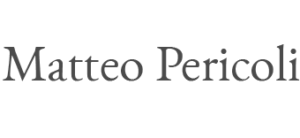di Matteo Pericoli
Più che in altre tecniche di rappresentazione, nel disegno al tratto il processo decisionale e le conseguenti omissioni possono essere lette con chiarezza. Un disegno fatto di sole linee deve parlare in modo deliberato e chiaro. Lo schizzo, la pittura o la fotografia hanno un rapporto meno filtrato con la realtà. Trasferiscono in modo più diretto (compatibilmente con la tecnica stessa) come il cervello interpreta il mondo.
Un disegno fatto di linee compiute (cioè con un chiaro inizio e una fine) prima di diventare tale deve attraversare un ulteriore processo analitico durante il quale chi disegna si domanda «ho bisogno di quest’altra linea per descrivere ciò che ho già mostrato con questa?» oppure «di quante linee ho bisogno per rendere questo dettaglio il più chiaro possibile senza usare troppe linee?».
I disegni al tratto sono ovviamente strettamente imparentati con (o provengono dai) disegni architettonici — disegni per lo più tecnici, ricchi di dettagli e con proprie regole sintattiche. Infatti, sono spesso dei “documenti” il cui compito è trasmettere informazioni ben precise sia sull’estetica sia sui dettagli di un edificio. Più è chiaro un disegno architettonico, più è facile “leggere” le qualità compositive e costruttive di un progetto.
Stavo ancora lavorando nello studio dell’architetto Richard Meier quando, nel 1998, decisi di provare a usare quelle stesse linee che usavo al lavoro per raccontare Manhattan nella sua interezza. Avevo appena preso il battello della Circle Line e circumnavigato l’isola per cercare di vedere ciò che m’era stato fino a quel momento invisibile (standoci dentro): la città stessa. Avevo deciso di provare a trasferire quel progredire lento e rivelatore della gita in battello in un disegno anch’esso lungo e dettagliato (ci sono poi voluti anni per completare i due rotoli dei profili est e ovest di Manhattan) che mostrasse tutto invece di solo alcune parti.
In fondo, una questione che mi assillava da quando mi trasferii a New York nel 1995 era proprio che la città veniva descritta a pezzi, aree, quartieri — con i famosi edifici che svettano sugli altri e con poco rapporto col resto — ma sembrava difficile da afferrare in modo integrale. Mi domandai: che impressione mi farà alla fine l’aver disegnato tutto senza alcuna esclusione? E se disegnerò ogni cosa che si vede dal fiume con il minor numero di linee possibile, con delle onde buffe, senza mai misurare o usare un righello, il risultato sarà un qualcosa di vivo come la città stessa? Qualcosa con cui i bimbi vorranno interagire? Che vorranno colorare?
Il disegno al tratto è innanzitutto uno strumento cognitivo. Nel voler provare a disegnare tutto, cioè ogni cosa, speravo di arrivare a conoscere meglio e poter condividere la città come fosse, appunto, un unico oggetto. Mi resi conto ben presto che quel tutto che stavo disegnando in Manhattan Unfurled era molto di più della somma di tutte le sue piccole parti; che disegnando ogni cosa si finisce sì per imparare molto, ma anche che non è ben chiaro cosa si impari. È una diversa forma di conoscenza. È forse più un senso di profonda familiarità o intimità verso un luogo che non è più solo fisico.
Lo stesso accadde anni dopo con London Unfurled, l’altro progetto di disegno urbano su due lunghi rotoli di carta. Nel caso di Londra, nel giro di alcuni mesi passai dal non sapere praticamente nulla di una città dove non avevo mai vissuto a conoscerne tutti gli edifici che si affacciano sul Tamigi. Durante il lavoro, tutto quello che disegnavo del profilo di Londra mi si fissava in testa linea dopo linea, spesso prendendo il posto dell’immaginario che mi stavo creando della città dove mi ero appena trasferito (Torino).
Per riuscire a osservare e fare veramente nostra una cosa è quindi necessario disegnarla, a mano libera e possibilmente al tratto, cioè con delle linee ragionate. Per quello che mi riguarda, non c’è altro modo. Dopo sette anni che ci vivevo accanto, dovetti infatti disegnare la vista dalla mia finestra sull’Upper West Side di Manhattan per accorgermi che non l’avevo mai veramente vista. Finestre sul mondo (e, prima, The City Out My Window) nasce dal desiderio di svelare, tramite il disegno, quanto la quotidianità di ciò che si trova al di fuori della nostra finestra sia spesso invisibile ai nostri occhi inconsapevoli. E come, soffermandoci su ciò che abbiamo sempre sotto il naso, il nostro sguardo non finisca per riflettersi su di noi.
La collaborazione con gli scrittori di Finestre sul mondo non ha fatto altro che rafforzare quanto, come nella scrittura, il potenziale narrativo del disegno al tratto si nasconda nella qualità di ogni singola linea — nella sua abilità cioè, in quella precisa posizione e in nessun’altra, di trasmettere il massimo delle informazioni con il minimo sforzo di lettura.

Pagina99, 21 gennaio 2017