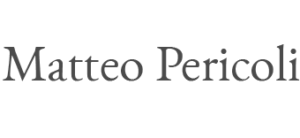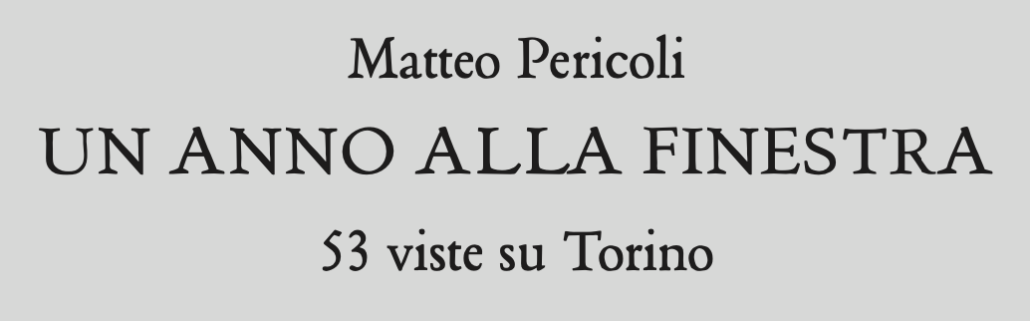Il World Trade Center risulta più alto della Willis Tower di Chicago
I rivali attaccano: “Antenna camuffata da guglia”. A novembre il verdetto
di Matteo Pericoli
La Stampa, Cultura & Spettacoli, 8 ottobre 2013
Perché un primato sia veramente tale, deve essere innanzitutto verificato e in qualche modo certificato. Dopo sette anni dall’inizio dei lavori, il 2 maggio scorso viene finalmente issata l’ultima porzione di un enorme pinnacolo alto 124 metri in cima al nuovo grattacielo del World Trade Center (inizialmente noto come Freedom Tower, ma ribattezzato One World Trade Center nel 2009). Quando, nel giro di poche ore, la Port Authority of New York & New Jersey (vale a dire la proprietà dell’intero complesso) dichiara in un comunicato stampa, con un pizzico di arroganza, che «una volta completato, con i suoi 1776 piedi di altezza (541 metri) One WTC sarà l’edificio più alto dell’emisfero ovest», la reazione da parte di chi tali primati non li prende alla leggera non è di unanime accordo.
Perché? Per motivi linguistici e architettonici. Nel comunicato stampa si parla di «edificio» («building»), mentre in realtà si sarebbe dovuto usare, preventivamente, il termine meno specifico di «struttura». Infatti, i primati aggiudicati alle strutture alte sono suddivisi in tre categorie: 1) altezza architettonica (quella comunemente accettata per la definizione di «edificio»), cioè dalla base fuori terra fino alla punta architettonica, vale a dire incluso un eventuale pinnacolo (che abbia funzioni principalmente estetiche), ma non un’eventuale antenna, o ripetitore, o asta per bandiera, e così via; 2) altezza di utilizzo, cioè dalla base fino all’ultima quota abitata all’interno della struttura; e 3) altezza massima, cioè dalla base fino al punto più alto della struttura, qualsiasi esso sia (antenne e aste incluse).
Per districarci da questi pasticci linguistico-architettonici si riunirà a inizio novembre il «Council on Tall Buildings and Urban Habitat» di Chicago, fondato nel 1969 per stilare, una volta per tutte e senza dubbi, la classifica degli edifici più alti del mondo. Ma riusciranno a rimanere imparziali? Infatti, il «Council of Tall Buildings» ha sede a Chicago, la città della Willis Tower (fino a poco tempo fa nota come Sears Tower), nonché l’attuale detentrice del titolo di «edificio più alto dell’emisfero ovest» con i suoi 442 m di altezza architettonica, 413 m di altezza di utilizzo e 527 m di altezza massima.
La voglia di costruire sempre più in alto ha radici e tradizioni antiche. Senza andare troppo indietro nel tempo, nella stessa New York ci fu l’avvincente e, visti i tempi (erano gli anni 1929-1930), entusiasmante corsa al primato di altezza tra i grattacieli 40 Wall Street e Chrysler Building. La gara si consumò durante la costruzione, pressoché simultanea, dei due grattacieli. E finì con un colpo di coda, una mossa di furbizia ingegneristica, quando il famoso pinnacolo di completamento del Chrysler Building venne prima trasportato (di nascosto e rimpicciolito come un palo telescopico chiuso) in cima al cantiere, poi issato e infine, in poche ore, esteso a mo’ di canna da pesca per sorpassare l’ormai finito 40 Wall Street e regalare così il primato, durato poi solo un anno, al Chrysler Building.
E, senza andare troppo lontano, anche Torino ha dovuto di recente confrontarsi con la complessa questione se sconfiggere o meno un primato d’altezza. Infatti, il nuovo grattacielo della Compagnia di San Paolo alla fine non ce l’ha fatta a sorpassare la Mole Antonelliana e rimarrà più basso, anche se solo di una manciata di centimetri.
Dopo il comunicato stampa di maggio, in cui la «Port Authority of NY & NJ» si vantava che il One WTC fosse l’«edificio» più alto dell’emisfero ovest, è sorto un terribile dubbio. In un articolo in prima pagina del 10 settembre scorso, il Chicago Tribune si domanda se quel pinnacolo non sia forse un’antenna camuffata, abbassando quindi la quota dell’edificio vero e proprio, e lasciando così il titolo alla Willis Tower di Chicago. È vero che alla fine, per la città con l’edificio certificato più alto, c’è un premio che va oltre la questione di vanità; e cioè: più turisti, più prodotti da commercializzare e vendere, più diritti (legali, certificati) di vantarsene, affitti più alti, insomma un po’ più di tutto.
Intanto, in attesa della deliberazione del «Council on Tall Buildings» a inizio novembre, bisognerebbe forse soffermarsi a ripensare a questa ossessione così marcatamente fallica per gli edifici che a tutti i costi devono ergersi più alti degli altri, quando la vera magia dell’architettura è l’esatto opposto, cioè lo spazio pensato per essere percepito dal di dentro e che solo raramente possiamo cogliere nella sua interezza.
Ma, attenzione, una vittoria di New York e del One WTC potrebbe nascondere un’ironica sconfitta. Quattro anni fa, il «Council on Tall Buildings» ha cambiato le regole su come si misura l’altezza di un edificio: la base deve essere calcolata dal punto più basso di accesso pedonale. One WTD ha un ingresso secondario sulla facciata nord, che è più basso di cinque piedi rispetto a quello principale, sulla facciata sud. Dai fatidici 1776 piedi, numero che evoca l’anno della dichiarazione d’indipendenza statunitense, si passerebbe a un’altezza di 1781 piedi, e quindi a una data che, volendo, potrebbe ricordare, a vostra scelta: la scoperta del pianeta Urano, la fondazione di Los Angeles, o la pubblicazione della Critica della ragion pura di Kant.